|
In
ricordo di mio fratello
Giorgio
Ravelli
Gianni
Roghi nella rivista L'Europeo 3/1971
Siamo andati a vedere la preparazione del lancio del satellite San Marco. Dal
poligono galleggiante di Formosa Bay (Kenia) partirà entro un mese il
satellite scientifico italiano: il progetto, appoggiato dal governo, è
finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e il costo complessivo è
previsto in quattro miliardi e mezzo.
A
cavalcioni di un tubo d’acciaio, su un vuoto di una quarantina di metri, un
po’ come Harold Lloyd sul grattacielo, l’ingegner Giuseppe Spampinato mi
spiega il razzo. Anzi, lui dice il vettore. Mi ha fatto salire quassù (io
sono a cavalcioni di un altro tubo di fronte a lui, e ogni tanto do un’occhiata
al mare verde sotto i piedi) per mostrarmi la panoramica delle due
piattaforme, quella di lancio e quella d’appoggio. Dalla piattaforma San
Marco, verso la fine di gennaio o ai primi di febbraio, partirà il
satellite scientifico italiano. Noi ci siamo arrampicati sulla più alta
torre dell’altra piattaforma: la Santa Rita.
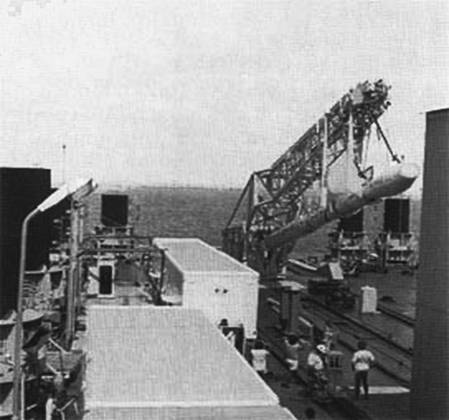
L’ingegner
Spampinato, trentotto anni, catanese nato a Trieste, maggiore del genio
aeronautico, è il direttore della grande baracca. Per la precisione, il
supervisore meccanico del razzo e delle infrastrutture a terra. È l’uomo
che porta avanti l’Italia spaziale, sotto la direzione programmatica del
professor Luigi Broglio, ordinario di costruzioni aeronautiche dell’università
di Roma, generale dell’aviazione. Spampinato dondola le gambe nel vuoto e
sorride: le cose, dice, stanno andando bene. Gli chiedo se è vero che è
stato lui a eseguire il più bel lancio del razzo Scout negli Stati Uniti.
Si schermisce ma poi finisce con l’ammettere: “È stato nel dicembre del
’64, al poligono della NASA in Virginia. L’equipe italiana doveva
dimostrare agli americani che ormai era matura per lo Scout a quattro
stadi. L’anno prima avevamo lanciato un bistadio
per imparare, sempre in Virginia: era andata bene. Nel marzo ’64
avevamo fatto un altro lancio da Formosa Bay, qui sulla costa del Kenia,
per provare il poligono su piattaforma in mare: bene anche qui. I1 lancio
del quadristadio era l’esame di laurea. Gli
americani ci hanno detto che nessuno Scout era mai stato sparato così
perfettamente”.

Le
due piattaforme brulicano di uomini e cose. Uomini bianchi e uomini neri.
Gru, montacarichi, enormi ruote dentate, cavi. “C’è ancora un po’ di
confusione”, dice Spampinato quasi a chiedere scusa, “ma ormai il tempo
stringe. Poi, vede, lo spazio non è molto, non siamo a Cape Kennedy”. La
piattaforma San Marco, da cui partirà il razzo, è di origine USA: serviva a
trasbordare merci dalle navi ai battelli e alle chiatte là dove non
esistono porti. È dotata di venti zampe mostruose, cilindri di acciaio
azionati da martinetti pneumatici, che ora s’innalzano al cielo ma che una
volta sul luogo s’immergeranno fino a posarsi solidamente sul fondo. Nel
centro, un lungo capannone, e nel capannone il gran razzo coricato,
ventitre metri di lunghezza, venti tonnellate di peso. È lo Scout costruito
dalla Ling Temco Vought. Nel capannone, tutto luci colorate misteriose,
aria condizionata, aggeggi strani, tecnici che si muovono silenziosi, quasi
astratti, c’è già il clima lunare. Mi ha fatto un certo effetto, poco fa,
durante la visita, udire improvvisamente uno di questi tecnici parlare e
dire cose incomprensibili, ma in romanesco. Anche il linguaggio di Alberto
Sordi può dunque andare bene per la ionosfera.
Appollaiato
sul suo tubo aereo, Spampinato mi spiega che lo Scout viene montato stadio
per stadio sul suo lanciatore, in posizione orizzontale. Quando tutto sarà
pronto, la torre metallica del lanciatore si solleverà portando con sé il
razzo, e sistemandolo così in posizione verticale di lancio. A questo punto
verrà praticato un foro nella piattaforma, proprio sotto la base del razzo,
affinché i gas di scarico, al momento della partenza, sfoghino direttamente
in mare e non sulla piattaforma, per evitare pericolose vibrazioni. Quando
avrà inizio il conto alla rovescia la piattaforma San Marco sarà lasciata
sola col suo razzo, in mezzo alla Formosa Bay. I tecnici opereranno dalla
piattaforma numero due, la Santa Rita, collegata alla prima da una ventina
di cavi sottomarini, diciassette dei quali forniti dalla Pirelli.
La
Santa Rita, che è un poco più piccola, rappresenta la centrale di
controllo: su di essa, oltre al radar, sono piazzati i vari gruppi
elettronici di comando. È una piattaforma a tre gambe, che serviva all’ENI
per prospezioni petrolifere. Una terza piattaforma, ancora più piccola,
dotata di centrale elettrica indipendente, completerà la flotta insulare.
La torre sulla quale stiamo discutendo come uccelli marini non è altro che
una delle tre zampe della Santa Rita: anch’essa, azionata da cricchi
mostruosi, scenderà nelle acque giallognole della Formosa Bay per ancorare
lo zatterone di ferro. Il supervisore delle piattaforme è un napoletano,
l’ingegnere Gennaro Orsi, capitano del genio aeronautico.
Ma
siete tutti militari?, domando a Spampinato. “I1 novanta per cento del
personale è dell’Aeronautica”, risponde, “ed è un fatto un po’ curioso
perché, come vede, stiamo lavorando sul mare”. Gli scienziati e i tecnici
del satellite fanno parte, in prevalenza, dell’università di Roma. I1
supervisore della parte elettronica del satellite è l’ingegnere professor
Giorgio Ravelli, anche lui comunque imparentato col genio aeronautico.
Questo Ravelli, dico a Spampinato, me lo ricordo bene; era un mio compagno
durante la Spedizione Zoologica Nazionale in Mar Rosso del 1952-53. Allora
faceva l’università (oggi ha trentasette anni), e aveva già inventato
diabolici sistemi d’illuminazione subacquea per il nostro film a colori, il
famoso “Sesto continente”. Lavorava con un cacciavite, una pinza, quattro
valvole e un po’ di nastro isolante, e combinava prodigi, lo chiamavamo Età
Beta. Sì, sorride Spampinato, è un cervello che si è guadagnata la
carriera. I1 supervisore invece del complesso tecnico in generale è il
professor Michele Sirinian, assistente di
Broglio. È uno dei più vecchi: quarantatré anni.
Tutti gli altri hanno un’età che varia fra i trentacinque e i trentasette.
I1 decano è l’unico marinaio qui presente: il comandante Wolfango Mandini,
cinquantaquattro anni. Gli ho chiesto come se la cavano gli aviatori su
queste zattere, ha risposto “non c’è male”.
Con Cavour al
tavolo spaziale
Il
progetto San Marco, appoggiato dal governo, è finanziato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche. La gestione è del Centro ricerche aerospaziali
dell’Aeronautica in collaborazione con l’Università di Roma. Spampinato mi
dice che il costo complessivo è previsto in quattro miliardi e mezzo:
“Veramente niente a confronto delle spese congeneri americane”. Con questo
lancio, l’Italia si confermerà “terza potenza spaziale insieme alla
Francia”, dietro Stati Uniti e Unione Sovietica. “Non è ovviamente il
caso”,dice Spampinato, “di parlare di competizioni: ma rimane positivo che
l’Italia acquisisca una nuova tecnica di ampie prospettive future”. Per
potersi “sedere al tavolo spaziale”, come direbbe Cavour, non occorre
andare sulla luna, ma dimostrare di avere una voce seria in capitolo.
Questo
lancio, chiedo, sarà tutto italiano? Sì, dice Spampinato, se si eccettua
ovviamente il vettore. Ma oggi i razzi si comprano sul mercato, e non
avrebbe senso economico impiantare una fabbrica italiana per i pochi
vettori che occorrono al nostro programma. Integralmente italiano è invece
il satellite, che è un gioiello di tecnica, oltreché qualcosa di originale anche
sul piano teorico. Soltanto italiani, infine, sono i piani di lavoro e gli
stessi tecnici. Il San Marco sarà il primo satellite al mondo lanciato da
una piattaforma in mare. Le maestranze italiane che sono qui sulla costa di
Mombasa da cinque mesi sono una sessantina: si tratta in prevalenza di
giovani sottufficiali del genio aeronautico; le inflessioni meridionali
sono le più comuni. Sono stati assunti, per le fasi preparatorie, una
cinquantina di indigeni, manovali, montatori, brasatori,
eccetera, ciò che ha reso ancor più cordiali i rapporti con il governo
keniota. Dunque niente americani? “Li abbiamo invitati, naturalmente”, dice
Spampinato, “e manderanno una delegazione di osservatori per assistere al
lancio”.
Parliamo del
satellite. A che cosa serve? “È un satellite per la ricerca scientifica”,
risponde Spampinato. “I1 suo lavoro sarà di rilevare la densità dell’aria
al limite estremo della ionosfera. In questa regione, ancora
imperfettamente conosciuta, l’atmosfera è estremamente rarefatta, le molecole
d’aria sono isolate e molto distanziate. Il satellite le incontrerà e darà
il rilevamento con continuità, girando intorno al pianeta su un’orbita
equatoriale piuttosto bassa, ma costante. Questo satellite, con il suo
lavoro, coronerà tutta una serie di studi prettamente italiani sul
problema, durati quattro anni, e fornirà una somma di dati particolarmente
utili ai fini della ricerca spaziale. Gli americani, per esempio, sono
molto interessati alla buona riuscita del nostro programma”.
E
il satellite com’è fatto? “Peserà circa 115 chilogrammi. Adesso è negli
Stati Uniti, dove lo stiamo adattando al quarto stadio dello Scout. Poi
verrà inviato qui per via aerea. È composto da una sfera di massa interna
pesante, e di un involucro leggero. Quando incontrerà una maggiore densità,
e cioè quelle tali molecole isolate e distanziate verrà impercettibilmente
frenato: la massa pesante interna, che è sostenuta da una bilancia, sarà
indotta a venire avanti per effetto di inerzia, così come succede a un
passeggero di un’automobile che frena. Questi spostamenti agiranno su
speciali resistenze elettriche, che daranno via radio l’informazione in
codice. I rilevamenti saranno captati e decodificati da una nostra apposita
stazione a Nairobi”.

Adesso lanciano,
poi si vedrà
L’8
novembre scorso le piattaforme sono partite a rimorchio dal porto di
Mombasa, hanno affrontato nuovamente l’Oceano Indiano, sono felicemente
arrivate al poligono prestabilito, la Formosa Bay (l’isola di Formosa,
evidentemente, non c’entra niente). Questa baia è poco a nord di Malindi, graziosa cittadina del Kenia. È stata scelta
perché riparata dai venti più pericolosi, quelli meridionali, dal capo Ngomeni. Le acque su cui le piattaforme allungheranno
le zampe per ancorarsi sono fra le due e le tre miglia dalla costa, cioè al
limite delle acque territoriali keniote. I1 punto non è proprio
sull’equatore, ma leggermente a sud: 2 gradi e 8. Il vettore dovrà eseguire
la correzione e il satellite dovrà entrare nella sua orbita equatoriale
subito dopo il lancio.
L’ingegner
Spampinato mi guida nuovamente nella discesa da trapezisti dalla torre
della Santa Rita, mi presenta i collaboratori. C’è fervore, ottimismo,
orgoglio a ogni livello. Quasi nessuno era mai stato in Africa prima di
questa lunga esperienza, ma nessuno si lamenta del clima umido, delle
piogge, del calore. Nessuno abita nei lussuosi alberghi turistici ad aria
condizionata: gli stessi dirigenti vivono in un alberghino di seconda
categoria. Di sera, per tirare le dieci, si scatenano battaglie allo
scopone scientifico. Pare che il tenente colonnello ingegner Roberto Solimena, supervisore delle stazioni radar, sia maestro
dello spariglio in fase offensiva, mentre l’ingegner Gianfranco Manarini, supervisore della guida e controllo del
razzo, è ampiamente dotato nella difesa del settebello da mazziere.
Ci
sono anche i sommozzatori, che hanno lungamente esplorato i fondali dove
devono appoggiarsi le gambe delle piattaforme. Le acque non sono profonde,
dicono: sui nove metri circa; ma piuttosto torbide. In principio c’era una
gran paura per i pescecani, e i sommozzatori venivano inviati sul fondo
dentro gabbioni di ferro. Ma passando i giorni, di squali non se ne
vedevano proprio, così che alla fine le gabbie sono state eliminate e i
sommozzatori hanno continuato a tuffarsi liberamente.
Con
questo lancio, dice Spampinato il nostro programma sarà concluso, speriamo
felicemente come fin qui è proceduto. Che cosa accadrà dopo? Mah, dovranno
decidere il governo e il Consiglio nazionale delle ricerche. Quattro anni
per arrivare a sparare il pallone intorno all’equatore, per farlo bene. Poi
si potrà andare avanti con nuovi programmi più ambiziosi, rimanere al passo
con il progresso tecnico e scientifico, tanto più che i francesi ci danno
dentro con molte energie. Oppure, per la storia delle alluvioni, potrà
venir rimesso tutto nel cassetto. E allora sarà rimasto il ricordo di una
bella avventura, in questo caso un ricordo un po’ amaro. Ma Spampinato e i
suoi sono ottimisti. Siamo o non siamo diventati la terza potenza spaziale,
con quattro soldini?
Estratto da Sesto
Continente di Folco Quilici
FOTOGRAFO E SCRIVO
Prima macchina fotografica
nelle mie mani fu una Rolleicord di mia madre
pittrice. Come fotografa amava la visione reflex e il formato quadrato, dal
quale traeva solo in qualche caso stampe in formato orizzontale o
verticale. Quella preferenza e quel gusto mi sono state trasmesse con il
DNA di famiglia, tant’è vero che pur ereditando (da mio padre) una Leica “anni Quaranta”, splendida e completa di borsa in
pelle e tre obiettivi, la cambiai con una delle prime Hasselblad
6x6; senza vantaggi dal punto
di vista economico ma con
massima soddisfazione nel lavoro. Infatti, aiutato dalla Fowa, ho continuato e continuo a lavorare con l’Hasselblad passando di modello in modello e
collezionando vari obiettivi, con un amore particolare per il magico
Super-Wide.
Sul mio inizio come
fotografo del mare e del suo mondo sommerso e la mia prima esperienza con Sesto
Continente, del ’52, debbo ricordare un alleato prezioso, un coetaneo
ventenne, futuro ingegnere spaziale, Giorgio Ravelli. Dopo audaci
esperimenti nella vasca da bagno di casa, lui ideò un blimp
con flash a lampadine usabile sott’acqua, esattamente come in superficie. E
perfezionò poi in
Mar Rosso a tal punto quel
suo marchingegno, da precedere d’oltre un anno i laboratori specializzati, tanto
da consentirci di piazzare i risultati dei nostri lavori molte lunghezze
avanti le altrui immagini subacquee a colori; e ci offrì la soddisfazione
di veder pubblicate due volte nostre immagini su “Life” (il
top dei top delle riviste
illustrate, allora).
Citando gli inizi, vorrei
qui aggiungere alcune parole sulle difficoltà di noi pionieri. La prima
dipese dai luoghi isolati ove operammo; atolli d’Oceania,
coste africane, Artico, Amazzonia lontani qualche migliaio di chilometri da
laboratori di sviluppo e stampa; di conseguenza potevamo vedere i risultati
ottenuti dalle nostre foto (sulle quali gravavano sempre dubbi di riuscita)
solo mesi e mesi dopo averle scattate (spedizioni e missioni erano
interminabili: quasi un anno per Sesto Continente, un anno per
Ultimo Paradiso, etc. etc.). S’aggiungeva, a questa, un’altra difficoltà non
indifferente: il dover affrontare con scorta limitata di pellicola lunghi
tempi di lavoro. Occorreva scattare… solo a colpo
sicuro! (ricordino questo i signorini di oggi, ricchi di schede
elettroniche con immagini a disposizione in quantità ieri inimmaginabili; e
per di più subito visibili)…
|